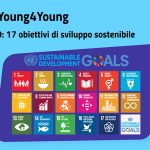Nel corso del tempo, il concetto di benessere ha subìto una trasformazione profonda. Oggi è possibile configurare l’idea di benessere come una visione articolata e integrata, che abbraccia dimensioni sociali, ambientali, istituzionali e individuali.
Per esplorare questa evoluzione e comprendere meglio le sfide e le opportunità legate alla misurazione del benessere, abbiamo intervistato il professor Enrico Giovannini, due volte Ministro della Repubblica, economista e accademico di rilevanza internazionale. Il professor Giovannini ha ricoperto ruoli di primissimo piano nell’elaborazione di nuovi strumenti e indicatori per valutare il progresso sociale e lo sviluppo sostenibile, contribuendo in maniera determinante alla definizione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. È stato Chief Statistician dell’OCSE, Presidente dell’ISTAT e fondatore dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).
L’intervista è stata guidata e ispirata da un recente studio pubblicato per il Joint Research Centre della Commissione Europea.

Come è cambiata la definizione di benessere nel tempo?
«Mi faccia tornare al 1836, quando Melchiorre Gioia, pensatore, economista e filosofo italiano, scrisse La Filosofia della Statistica, in cui provò a identificare di cosa si debba occupare la statistica e cosa debba misurare. In primo luogo, diceva di dover “cominciare dall’ambiente” (il suo riferimento era all’agricoltura), ovvero dal luogo in cui gli uomini vivono. E poi misurare la popolazione (cioè la demografia) e cosa si fa per vivere, dunque l’economia. E poi, cosa si fa quando non si lavora, dunque, la società, e cosa fa lo Stato per consentire a tutto questo di realizzarsi. Infine, diceva, deve misurare la povertà e la felicità.
Gli economisti che fondarono la disciplina economica erano, prima di tutto, filosofi morali. In quel periodo, l’economista italiano Genovesi combatteva contro la scuola anglosassone e parlava di beni comuni e collettivi. Purtroppo, vinse una visione dell’economia basata fondamentalmente sui beni privati e sull’individuo, che ancora oggi appare dominante».
Poi abbiamo cominciato a misurare il PIL…
«Era il 1944, quando il governo degli Stati Uniti chiamò gli economisti inglesi e americani a confrontarsi su come calcolare il PIL, cioè il Prodotto interno lordo. L’intenzione “politica” era quella di imporre a livello globale una certa visione del mondo economico, e dunque della politica, attraverso le organizzazioni di Bretton Woods (ONU, Fondo Monetario, Banca Mondiale) e il sistema di contabilità nazionale. Ebbene, il governo degli Stati Uniti scelse l’impostazione inglese, basata sulla quantità di produzione e non quella della scuola americana, basata sul consumo e il benessere, in quanto il problema politico che avevano ben presente era quello di dimostrare che il capitalismo era in grado di produrre più beni rispetto al comunismo. Negli anni ’50, iniziò quindi la definizione del Sistema di contabilità nazionale, al cui interno si calcola il PIL, una variabile che, dal secondo dopoguerra in poi, è cresciuta in maniera straordinaria. E con il PIL sono cresciuti anche l’educazione, la salute e, in generale, la qualità della vita.
Negli anni ’70, molti economisti, sociologi e studiosi richiamarono l’attenzione sui fenomeni sociali. Questo portò le Nazioni Unite, negli anni ‘80, a produrre l’Indicatore di sviluppo umano, un indice composito basato su tre componenti: PIL, educazione e salute. Questo approccio, semplice ma innovativo, era visto anche come un antagonista del Washington Consensus, ovvero l’idea che i Paesi dovessero essere aiutati solo a produrre di più».
Ma ad un certo punto questi indicatori non bastavano più…
«Negli anni 2000 si è molto investito sulla misura della felicità e della qualità della vita, variabili da valutare principalmente attraverso una valutazione soggettiva. Anche in questo caso, il fondamento deriva da una particolare visione filosofica, risalente a Bentham, in base alla quale nessuno (né gli statistici e i sociologi, né i politici) può sostituirsi alle persone nel determinare cosa determini la loro felicità, cioè, per esempio, se il lavoro sia più importante della salute o della ricchezza.
Io ero all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) negli anni 2000, come direttore delle statistiche e chief statistician. Decidemmo quindi di dedicare grande attenzione alla misura del benessere e dello sviluppo sostenibile. Dopo il primo Forum mondiale che organizzai nel 2004 a Palermo, lanciammo un progetto globale proprio sulla misurazione del benessere e del progresso delle società. Quel lavoro condusse poi alla creazione della ben nota Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi in cui affrontammo il tema con l’aiuto di ben cinque Premi Nobel in economia. Il messaggio fu chiaro: dobbiamo (e possiamo) misurare le diverse dimensioni del benessere (economiche, sociali e ambientali), la sua distribuzione tra i diversi gruppi sociali e la sua sostenibilità nel tempo. Guardammo quindi alla misurazione non solo del capitale economico, ma anche di quello naturale, umano e sociale, alla qualità delle relazioni tra persone, alla qualità delle istituzioni, ecc. Da allora, molti Paesi sono andati nella direzione che indicammo come OCSE, che diventò, anche dopo la mia uscita (nel 2009), l’istituzione internazionale più impegnata su queste tematiche».
Che cosa sono gli indicatori di benessere e sviluppo sostenibile?
Su un piano metodologico, esistono tre approcci possibili alla misurazione del benessere e dello sviluppo sostenibile:
- estendere i conti nazionali, ossia creare “conti satellite” sul benessere delle famiglie, la sanità, l’educazione, ecc. Tuttavia, questo si scontra con il problema della metrica unica: ad esempio, è difficile attribuire un prezzo alla perdita di una specie di farfalle come parte della biodiversità;
- costruire indicatori compositi, combinando dati sulle diverse dimensioni del benessere (salute, lavoro, rapporti personali, ambiente, ecc.), attraverso tecniche statistiche che generano indici sintetici;
- utilizzare una dashboard di indicatori, ovvero un “cruscotto” riempito di dati (espressi in unità di misura diverse), che coprono i diversi aspetti del benessere. Questo approccio, però, ha il limite di non fornire un numero unico come fa il PIL o l’approccio degli indici compositi e quindi la comunicazione del cruscotto è complessa, soprattutto per il grande pubblico.
Ad esempio, nel 2010, dopo il mio passaggio dall’OCSE alla presidenza dell’ISTAT, nel 2010 lanciammo il progetto che costruì gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES), pubblicati dal 2013 in poi.
Infine, nel 2015, con la firma dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, con i suoi 17 obiettivi e 169 target, il mondo ha adottato un modello basato proprio su una dashboard di indicatori, a partire dai quali alcuni istituti di ricerca hanno costruito indicatori compositi.
Questa, in estrema sintesi, è la storia di un concetto che si è evoluto nel tempo, anche grazie al progresso delle tecniche statistiche per misurarlo. Tuttavia, oggi non abbiamo ancora trovato il Sacro Graal».
Solo dalla Commissione Europea sono stati individuati oltre 1.000 indicatori…
«Che vengono usati dalle varie direzioni e agenzie della Commissione Europea per molte finalità diverse».
Qual era l’obiettivo della ricerca che lei ha coordinato presso il Joint Research Centre della Commissione?

«L’obiettivo che ci eravamo dati era quello di costruire indicatori di Benessere Sostenibile e Inclusivo, una dizione, come può vedere, molto simile a quella del BES. In realtà l’approccio che abbiamo seguito è stato abbastanza diverso. Siamo partiti dalla costruzione di un consenso tra tutti i servizi della Commissione Europea, riducendo il numero di indicatori che erano 1.100, cioè quelli utilizzati in modo specialistico dalle singole direzioni, selezionando con loro quelli più rilevanti per misurare il benessere sostenibile ed equo. Siamo così scesi prima a circa 150 indicatori e poi ulteriormente a 50 per descrivere, da un lato, gli elementi che incidono sul “benessere attuale”, dall’altro quelli che incidono sul benessere futuro, tutti descritti attraverso indicatori compositi delle singole componenti. Si tratta di un approccio innovativo, che ha prodotto un “cruscotto” diverso da tutti gli altri esistenti. Per illustrarlo facciamo l’esempio della guida di un’automobile. Quando lei guida un’automobile non guarda soltanto il tachimetro: controlla anche quanto carburante le resta, la temperatura del motore, la pressione degli pneumatici, l’equilibrio del veicolo e molte altre cose. Se siamo capaci di controllare un sistema complesso come un’automobile, perché dovremmo diventare “stupidi” quando osserviamo il benessere della società, limitandoci a un unico numero?
Ecco, immagini di avere un cruscotto davanti. Non il classico cruscotto che le dice come sta andando l’economia, il lavoro, la salute o l’ambiente, ma un sistema più evoluto. Immagini di avere un tachimetro che rappresenta il benessere odierno, combinando diverse dimensioni e andando oltre il PIL. Un altro indicatore, il benessere di domani, sarebbe come il navigatore della sua automobile, che le indica la direzione da seguire, mostrandole se sta andando sulla strada giusta per arrivare a destinazione. Poi c’è una serie di indicatori che misurano i meccanismi che le consentono di viaggiare: ad esempio, le diverse forme di capitale, che possiamo paragonare al carburante a nostra disposizione. Poi c’è quello relativo all’equità, simile a quello che le dice se la pressione degli pneumatici le garantisce il bilanciamento dell’auto. Poi c’è quello sulla qualità delle istituzioni, analogo alla temperatura del motore, che le fa comprendere se la società sta entrando in ebollizione».
Emerge in tutto questo anche una sfida nella comunicazione. Perché, di fatto, la straordinaria efficacia del concetto di PIL è legata anche alla sua comunicazione estremamente immediata, caratterizzata da un unico “numero”. C’è la sfida del dover imparare a comunicare tutto questo.
«Questa è una sfida enorme. Il successo del PIL nasce proprio dal fatto che è un numero unico, che esprime la quantità di beni e servizi prodotti. Sembra che, guardandolo, tutto sia contenuto lì. E ripeto, le correlazioni tra il PIL e altre dimensioni del benessere esistono e sono forti, soprattutto nelle fasi iniziali dello sviluppo, quando si esce da un’economia di sussistenza e si avanza nella complessità del sistema economico. Comunicare e “battere” questo tipo di informazione non è facile. Ci sono tre requisiti fondamentali per ogni misura che voglia essere integrativa o sostitutiva del PIL:
- Tempestività: grazie agli investimenti metodologici e di ricerca degli ultimi 50 anni, oggi disponiamo di dati sul PIL con una cadenza trimestrale, e in alcuni casi addirittura mensile, anche se essi vengono rivisti frequentemente. Tuttavia, se ci soffermiamo sui comunicati stampa relativi ai conti nazionali, vediamo che anche nella presentazione del PIL si dice cosa ne ha determinato la dinamica, ad esempio i consumi, gli investimenti, le esportazioni, ecc. Dunque, anche il quadro informativo odierno è, per fortuna, già complesso da comunicare, eppure ci siamo abituati a tale complessità, anche perché sono dati quasi in tempo reale. Nella comunicazione giornalistica, poi, si commentano variazioni del PIL di 0,1% o 0,2%, che rientrano nell’errore statistico: eppure, gli statistici sono riusciti a convincere gli utilizzatori che anche queste minime variazioni contino molto, anche se non è necessariamente vero e talvolta le revisioni cambiano addirittura il segno della variazione. Ciò che importa, comunque, è che sono dati molto tempestivi, il che stimola continui commenti su questi dati. Se un indicatore alternativo al PIL venisse pubblicato con uno o due anni di ritardo non potrebbe competere sul piano comunicativo. Di conseguenza, nel nostro programma di ricerca contiamo anche di fare stime flash degli indicatori che compongono il benessere attuale;
- Frequenza dei dati: il PIL non è solo pubblicato a frequenza annuale, ma trimestrale (peraltro, il mio primo incarico da giovane ricercatore dell’Istat fu proprio – negli anni 1982-1983 – produrre le stime trimestrali del PIL). Se un indicatore alternativo al PIL venisse pubblicato solo su base annuale sarebbe difficile riuscire ad avere lo stesso impatto dei conti nazionali. Per questo, nei prossimi mesi valuteremo la possibile di produrre stime trimestrali almeno dell’indicatore del benessere attuale;
- Proiezione sul futuro: nel tempo abbiamo sviluppato strumenti, come i modelli econometrici, che ci consentono di fare previsioni sul PIL e altre grandezze economiche. In questo modo il dibattito pubblico, soprattutto quello politico, si concentra anche su quello che potrebbe accadere domani. Di conseguenza, un indicatore alternativo che non si possa prevedere partirebbe già con un forte handicap. Ecco perché nel nostro progetto stiamo valutando quanti degli indicatori che compongono il benessere corrente e le altre componenti possono essere previsti con modelli di varia natura. Questo è cruciale, perché i politici adorano discutere del futuro, non del passato».
Sono rimasto affascinato da questa immagine del cruscotto che abbiamo davanti, quindi torno su quella: quali indicatori dobbiamo osservare con maggiore attenzione, almeno in questo momento, per capire dove stiamo andando e per orientarci in questa dashboard?
«Nel quadriennio 2016-2020 al Joint Research Center abbiamo sviluppato gli indicatori di vulnerabilità e resilienza delle economie e delle società europee, che sono poi entrati, con la pandemia, a far parte della narrativa politica della Commissione Europea. In particolare, abbiamo guardato ai rischi legati a shock tecnologici, sanitari, economici, geopolitici, ambientali, ed è oggi sempre più evidente quanto siano cruciali, proprio ora che l’Unione Europea si sta interrogando su come rispondere alle scelte della nuova amministrazione Trump.
Che ruolo hanno questi indicatori nel cruscotto? Sono il radar: oggi molte automobili sono in grado di segnalare se la distanza con l’auto che ci precede si sta riducendo pericolosamente, o se ci sono pedoni. Allo stesso modo, questi indicatori ci aiutano ad anticipare rischi e cambiamenti improvvisi del quadro in cui viviamo.
Ma anche altri indicatori sono importanti. Ad esempio, vediamo che la fiducia nelle istituzioni pubbliche si è ridotta negli ultimi anni. Questo aiuta a spiegare alcune scelte elettorali contro l’establishment. Misurare la fiducia nelle istituzioni ci permette di capire se il rischio principale sia l’insostenibilità istituzionale, piuttosto che quella economica o ambientale».
Come continuerà il lavoro di ricerca che state portando avanti, anche in relazione a chi inizierà ad adottare questa dashboard e gli indicatori che avete sviluppato?
«In primo luogo, stiamo aggiornando la base dati al 2023 e stiamo cercando di capire quando saranno disponibili quelli del 2024, probabilmente a fine anno. Come ho accennato, nei conti nazionali si fa ampio uso del nowcasting, ovvero di stime su eventi già accaduti recentemente. Anche nella stima del PIL, infatti, non tutti i dati sono immediatamente disponibili, quindi si utilizzano modelli di previsione a brevissimo termine. Lavoreremo per capire come questo approccio si possa usare per alcune componenti dell’indicatore di benessere sostenibile e inclusivo.
Personalmente, la mia speranza è che Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell’Unione – che normalmente pronuncia a settembre – possa utilizzare queste informazioni per far capire agli europei dove stiamo andando».
Nel corso del lavoro svolto, c’è qualcosa che l’ha colpita particolarmente, in relazione ai singoli Paesi, sul rapporto tra benessere, economia e PIL?
«Non siamo ancora entrati nell’analisi dettagliata dei singoli Paesi: l’intenzione è quella di coinvolgere gli uffici che si occupano dei vari Paesi per capire se si riconoscono nei risultati che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda l’Italia, emerge chiaramente che la dinamica dell’indice del benessere corrente corrisponde alla percezione comune della realtà, così come quella delle componenti da cui dipende il benessere futuro, in peggioramento negli anni 2021-2022, nonostante il forte rimbalzo del PIL dopo la pandemia».
Questo progetto che avete portato avanti con la Commissione Europea, cosa ci dice sullo stato di avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030? Ci sono indicazioni rilevanti da questo punto di vista?
«Se vogliamo valutare lo stato di avanzamento dell’Agenda 2030 nel suo complesso, dobbiamo fare riferimento ai Rapporti di Eurostat, dell’Istat e dell’ASviS (Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile) a livello italiano. Questi Rapporti mostrano che, sebbene l’Europa sia l’area più sostenibile del mondo, non sta avanzando nella direzione della sostenibilità come dovrebbe. Gli indicatori sintetici di ASviS per l’Unione europea, ad esempio, segnalano che su due obiettivi cruciali, quello relativo agli ecosistemi terrestri (Obiettivo 15) e quello sulla partnership globale (Obiettivo 17), oggi l’Europa è in una situazione peggiore rispetto al 2010. Se guardiamo all’Italia, per ben sei obiettivi su diciassette (povertà, disuguaglianze, condizioni dei sistemi idrici, ecosistemi terrestri, partnership internazionali e governance complessiva) la situazione è peggiorata rispetto al 2010.
Sull’Agenda 2030 siamo in grado di fare un monitoraggio dettagliato, anche a livello globale, e ciò che emerge è preoccupante. Il serbatoio del carburante si sta svuotando (cioè peggiora il capitale naturale e quello umano, si riduce quello economico) e la governance globale, ovvero la centralina elettronica della nostra automobile, mostra gravi difficoltà, rischiando di non attivare i giusti meccanismi di protezione per evitare shock come le guerre. Se leggiamo la sostenibilità in questo modo, vediamo quanto questo approccio sia concreto e vicino alla realtà, perché mostra che non possiamo concentrarci su un solo indicatore, ma dobbiamo considerare molteplici dimensioni contemporaneamente.
Un esempio significativo da questo punto di vista è quello delle Primavere Arabe del 2011: all’epoca, il PIL cresceva al cinque per cento e gli economisti erano tranquilli. Tuttavia, un fenomeno climatico determinò la siccità e bloccò la produzione di energia idroelettrica. Ci furono blackout, la carenza di produzione fece aumentare i prezzi dei generi alimentari. Questi fenomeni spinsero la popolazione a scendere in piazza, il che portò alla caduta di diversi regimi. Insomma, un problema ambientale ne determinò uno economico, che provocò una crisi sociale e infine una crisi istituzionale. Per comprendere davvero la sostenibilità di un processo di sviluppo è quindi necessario guardare simultaneamente a più fattori».