
Di cosa scrivere se pensiamo all’oggi e alla nostra Università Pontificia Salesiana, anzi a tutte le Università?
Mi sollecita la lettura di un piccolo ma prezioso testo di Andrea Principe (già Rettore dell’Università Luiss Guido Carli), “Università generativa”, pubblicato dal Mulino nel 2024.
Il testo è improntato sulla centralità di tre parole che dovrebbero, secondo l’autore, caratterizzare il futuro delle Università: Interdisciplinarietà, Internazionalizzazione, Innovazione. Tre I fondamentali, se si vuole formare giovani adulti capaci di affrontare le sfide del mondo del lavoro e non solo. Ma di fatto nel testo c’è una quarta parola, che è quella che mi colpito, ed è educability. Questa parola è intesa come la disponibilità ad apprendere non solo conoscenze, ma competenze, al saper essere e crescere come persone aperte al mondo. Educare vuol dire dare occasioni di comprendere il proprio percorso per diventare persone “adulte” nel senso di capaci di vivere in una società, qualunque essa sia, che dovrebbe accogliere il ragazzo in crescita. Parlare di educability vuol dire dare gli strumenti per “sopravvivere” in qualunque società, non risposte, strumenti di pensiero e conoscenza.
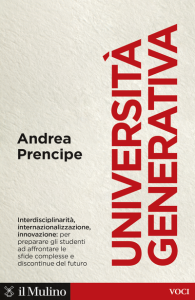
Per riuscire a porsi le giuste domande
Ci si domanda di fatto: a cosa deve formare una accademia?
Sembra quasi che si vogliano superare vecchi concetti legati veramente solo al sapere e si vada verso una “generatività” educativa e accademica, che apre al riconoscere e far sviluppare tutte le possibili potenzialità di uno studente. Ci si concentra e si propone pertanto lo sviluppo soprattutto del “saper essere” e del “saper diventare”: saper diventare nel senso di essere disponibili e aperti al cambiamento, alle sollecitazioni esterne. Si arriva a proporre l’importanza di “disimparare” per uscire da schemi rigidi con i quali diventa complesso dare risposte, ma anche porsi le giuste domande di ricerca.
«Una università capace di problematizzare, interrogare la realtà per creare nuove soluzioni a problemi concreti, con una attenzione alle intersezioni tra discipline, ambiti e ruoli per essere definita “generativa”; in tal modo crea conoscenza, sviluppa nuove idee e soluzioni». Accanto al concetto di educability, perciò, quello di “engagement” cioè lo sviluppo di metodi e approcci accademici che catturino l’attenzione perché portano le persone sentirsi parte di soluzioni, di scelte e sviluppo di responsabilità collettiva.
Lo sviluppo di tali capacità comporta pertanto l’abbandono delle specializzazioni per abbracciare l’interdisciplinarietà, la capacità di connettere e non solo di separare. Connettere materie, discipline e pensieri, per arrivare a far sì che lo studente possa elaborare il proprio sapere a partire dalle proposte fatte. Si riparte dalle idee di Stefan Collini, secondo il quale l’insegnamento dovrebbe essere inquietante e scomodo, nel mettere in crisi e in discussione le idee esistenti.
In effetti cosa vuol dire generare se non innovare, fare emergere qualcosa di nuovo? Per farlo ognuno di noi ha bisogno di spazio, di tempo, di prove ed errori, di fiducia e non chiusura. Di speranza potremmo dire, ma anche di gioia, di capacità di affrontare viaggi inesplorati. La generatività non è solo degli scienziati ma di tutti coloro che osano.
«Imparare a disimparare»
Leggere questo piccolo testo ci riporta all’insegnamento di Calvino, a quelle città invisibili che diventano possibilità per tutti.
Quale perciò la proposta? Quale il metodo proposto? Quello del creare dubbi, del lavorare su progetti, dell’imparare a porsi le giuste domande per poter avviare ricerche che diano risposte. E che le risposte appunto non siano date ma ricercate, costruire, eventualmente più volte. «Imparare a disimparare» è la proposta che Prencipe riprende da Dewey, un disimparare che non sia dimenticare ma saper governare il sapere, eliminando le conoscenze obsolete ma crescendo come direbbe Bernardo di Chartres, sulle spalle dei giganti per vedere oltre ciò che è dato.
Per queste ragioni la possibilità di essere Università generative passa dal concetto di educability, nell’ottica dell’offrire proposte che consentano di “educarsi”, di trovare la propria strada e non seguire quella già segnata.
Il testo si chiude di nuovo con un riferimento a Calvino e alle Città invisibili: «La memoria conta veramente se tiene insieme l’impronta del passato e il progetto del futuro, se permette di fare senza dimenticare quel che si voleva fare, di diventare senza smettere di essere e di essere senza smettere di diventare». Ci si chiede se queste parole siano mai state realmente prese in considerazione da chi, come docente di Università, riesce a proporre ai propri studenti una visione altra, non precostruita, non rigida, ma aperta appunto alla ricerca e all’innovazione, allo sviluppo di persone oltre che di professionisti, unico vero scopo delle accademie.







