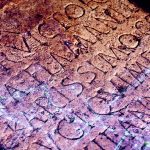«La fabbrica del futuro avrà due soli operai: un uomo e un cane. Il compito dell’uomo sarà nutrire il cane, mentre quello del cane sarà assicurarsi che l’uomo non tocchi la macchina, che farà tutto il lavoro». Con questa frase provocatoria, Warren Bennis, pioniere negli studi sulla leadership, immaginava il futuro del lavoro già nel 1988. Aggiungendo una nota tutta italiana, oggi la visione potrebbe diventare ancora più pessimistica: l’assenza di giovani nel mercato del lavoro, sommata all’avanzata dell’Intelligenza Artificiale, sembra lasciare spazio solo a scenari distopici. Ma è davvero così? Siamo destinati a un futuro lavorativo dove l’uomo viene completamente sostituito dalle macchine, o ci sono opportunità che ancora non vediamo? Marco Bentivogli, esperto in trasformazioni tecnologiche e lavoro, offre una strada per comprendere meglio cosa ci attende realmente.
Sfatiamo i falsi miti: l’intelligenza artificiale crea disoccupazione?
Una delle paure più diffuse legate all’IA è che possa alimentare la disoccupazione. Tuttavia, i dati raccontano una realtà diversa.
«La tecnologia non elimina il lavoro. Lo sposta. Lo trasforma. L’innovazione, più in generale parlando di intelligenza artificiale, di robotica, di macchine avanzate, fa male a chi non ce l’ha». Nei Paesi dove sono presenti più robot per lavoratore – come la Corea del Sud e Singapore – i tassi di occupazione rimangono alti. Questo perché le tecnologie, pur sostituendo alcune mansioni, generano al contempo nuovi lavori e interi settori economici. È quindi essenziale superare il falso mito della “macchina che ruba il lavoro” e concentrarsi su come essa possa trasformarlo.
La rivoluzione dell’IA: a che punto siamo?
Siamo nel pieno della seconda età delle macchine: mentre nella prima, con la rivoluzione industriale, si cercava di superare il limite fisico dell’uomo, potenziandolo attraverso l’uso della macchina, questa nuova era sta ampliando le sue capacità di conoscenza. Ciò che infatti si sta cercando di superare sono i limiti cognitivi degli esseri umani applicati alla produzione. L’Intelligenza Artificiale viene infatti progettata per svolgere compiti che amplino le capacità umane in termini di velocità, precisione, complessità o quantità di informazioni gestibili. Diversamente da quanto si possa pensare le nostre capacità sensomotorie, come afferrare un oggetto o compiere movimenti precisi, sono molto più difficili da emulare dall’IA rispetto alle nostre abilità cognitive. Affinché la paura della tecnologia ceda il passo ad una visione realistica è necessario avere consapevolezza di dove ci troviamo. Questo ci permetterà, inoltre, di prevedere su quali lavori l’IA avrà maggiormente impatto.
Il lavoro in Italia: tra Silver Tsunami e giovani invisibili
Entro il 2050 ci saranno 8 milioni in meno di italiani in età lavorativa (15-64 anni). L’Italia vedrà un drastico calo nella popolazione rispetto a oggi. Secondo i dati Istat, il rapporto tra chi lavora e chi non lavora (0-14 e over 65) passerà da circa tre a due nel 2023 a circa uno a uno nel 2050. Questo quadro si inserisce nel Silver Tsunami che sta colpendo l’Italia, definito nel 2023 dal New York Times come “un’ondata d’argento” che caratterizza la Penisola a causa della combinazione di bassi tassi di natalità e di un costante aumento dell’età media della popolazione.
«Paradossalmente, si dovrebbe pensare che un Paese consapevole di una simile situazione comprenda l’importanza di valorizzare i giovani, poiché saranno sempre meno numerosi e, quindi, più preziosi. Tuttavia, l’Italia sembra soffrire di un narcisismo che si manifesta nel fatto che persone anziane, anche novantenni, spesso affermano di essere le uniche capaci di svolgere certi compiti, creando un problema di continuità generazionale», afferma Bentivogli. Perciò è importante intervenire al più presto per evitare di non incorrere domani nel rischio di trovarsi senza una popolazione giovanile pronta a raccogliere l’impegno della produzione lavorativa. E questo, continua l’esperto del lavoro e delle sue tecnologie, «è un problema molto serio: l’educazione al passaggio del testimone è una educazione alla civiltà e alla democrazia. L’insostituibilità è un disastro perché abbiamo creato una situazione in cui mai come oggi le generazioni non si parlano. I quindicenni considerano i ventenni dei vecchi. I ventenni considerano i venticinquenni ormai morti e sepolti. I venticinquenni considerano i cinquantenni quasi degli zombie. Situazioni intergenerazionali oggi sono occasioni rare». E questo è un aspetto che dobbiamo ricostruire per formare i giovani di oggi alla trasformazione del lavoro di domani.
L’IA trasformerà il lavoro: come e perché
Secondo Bentivogli, l’Intelligenza Artificiale porterà sul lavoro tre effetti principali: l’effetto Generazione, l’effetto Sostituzione e l’effetto Integrazione. Vediamoli nel particolare.
- L’effetto Generazione creerà nuove opportunità e professioni. Come osservato dal World Economic Forum, il 65% dei bambini che oggi frequentano le scuole elementari faranno un lavoro di cui al momento non conosciamo nemmeno il nome. Il mercato del lavoro del futuro sarà caratterizzato da opportunità completamente nuove.
- L’effetto Sostituzione porterà alcune professioni tradizionali a diminuire di rilevanza o a scomparire venendo però sostituite. «Questo potrebbe far sorgere paure, ma in realtà nella storia questo è sempre accaduto. Nel Settecento quanti cocchieri che guidavano le carrozze c’erano e quanti cocchieri ci sono oggi? È chiaro che il mercato del lavoro cambia.»
- Infine, l’effetto Integrazione accrescerà le potenzialità di ogni professione, combinando le capacità umane con quelle delle macchine. Questo permetterà di aumentare efficienza e produttività. Le macchine sostituiranno l’uomo in alcuni task, ma apriranno la strada a nuove attività che oggi sembrano impossibili da gestire o anche solo immaginare. La collaborazione tra uomo e tecnologia diventerà una risorsa chiave per espandere le capacità umane e creare nuove opportunità.
Le professioni più esposte al cambiamento
Tutte le professioni subiranno un impatto dall’IA, ma quelle che richiedono livelli di istruzione medio-alti e un maggiore utilizzo di abilità cognitive saranno le più esposte. Minore sarà invece l’impatto nei lavori manuali e operai. È il cosiddetto paradosso di Moravec secondo cui, come dice lo stesso ricercatore informatico canadese, «è relativamente facile fare in modo che i computer mostrino prestazioni di livello adulto nei test di intelligenza o nel giocare a dama, e difficile o impossibile dare loro le competenze di bambino di un anno quando si tratta di percezione e mobilità».
Vari approcci, come quello sviluppato da Edward Felten, hanno permesso di stabilire il grado di esposizione delle differenti professioni misurando le varie abilità umane che vengono coinvolte, ponendole in relazione all’IA e analizzando infine i lavori maggiormente esposti. Ad esempio, per svolgere la professione di avvocato è necessario saper “ordinare le informazioni”. Secondo questo metodo, un avvocato viene considerato come esposto all’Intelligenza Artificiale, almeno per questa mansione. La misura finale di esposizione per ogni professione è data dalla media dell’esposizione di tutte le sue mansioni.
Formare i giovani oggi per il lavoro di domani
L’educazione, secondo Bentivogli, sembra essere la chiave necessaria per aiutare i giovani ad affrontare il futuro del lavoro. È però indispensabile non considerare l’AI una minaccia alla nostra umanità e non temere di conoscerla e utilizzarla.
L’esperto ha identificato tre sfide principali. Innanzitutto, educare all’IA, formando e diffondendo consapevolezza sulla stessa IA e sui cambiamenti in atto. Poi promuovere opportunità formative per educare, soprattutto le nuove generazioni, all’uso delle nuove tecnologie, accrescendo la consapevolezza delle capacità umane e di una mentalità critica: «Più conosciamo le cose che accadranno più avremo spazio di governarle e orientarle».
In seconda istanza, occorre educare con l’IA, e cioè usare l’Intelligenza Artificiale come strumento per migliorare l’apprendimento, personalizzando i percorsi formativi e colmando le lacune educative. L’IA, inoltre, può supportare il docente, alleggerendolo da tutte le attività che non rientrano nel patto educativo con i giovani. Questo può permettere agli insegnanti di concentrarsi maggiormente sulle relazioni e sugli aspetti fondamentali dell’educazione. L’IA offre un aiuto prezioso in molti contesti educativi; per esempio, può individuare e correggere errori ricorrenti che gli studenti si portano dietro nel tempo, talvolta persino fino all’università o al master, ma che spesso restano inosservati. Grazie a strumenti di analisi avanzati, queste difficoltà possono essere identificate e affrontate tempestivamente, migliorando l’efficacia del percorso formativo.
Infine, educare l’IA, e cioè addestrarla attraverso figure capaci di progettare e gestire le tecnologie in modo etico, in grado di rispettare i valori umani e prevenire la presenza di pregiudizi negli algoritmi che possono determinare rischi e problematiche a posteriori.
Dalla formazione STEM a quella STEAM
In Finlandia, i laboratori di falegnameria sono stati reinseriti nei licei classici, simbolo di un’istruzione integrata che unisce pensiero umanistico e tecnico. In Italia, invece, la scuola tecnica è considerata ancora di “serie B” e i licei continuano a separare mente e mani, cultura e pratica. «Il problema del nostro sistema d’istruzione, ha sottolineato Bentivogli, è infatti la compartimentazione che con l’IA sarà ancora più visibile». È tempo di cambiare prospettiva: le competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) e quelle umanistiche devono dialogare attraverso nuovi sistemi d’istruzione come lo STEAM (in cui la “a” sta per “arti”). Attualmente infatti i più preparati sono coloro che hanno unito il sapere umanistico a quello tecnico, perché hanno compreso che la tecnica ha bisogno di analisi critica, pensiero analitico e capacità tipicamente umane. «Abbiamo superato guerre e pandemie, e forse ne affronteremo altre, ma il vero errore è vedere il futuro come una catastrofe. Siamo nel secolo delle più grandi opportunità che ci siano mai state nell’umanità. Trasferire questo pessimismo non aiuta. Si tratta invece di un momento da sfruttare per formare lavoratori, studenti e cittadini pronti a stare nelle grandi transizioni tecnologiche e ad affrontarle come una sfida aperta tutta ancora da giocare».