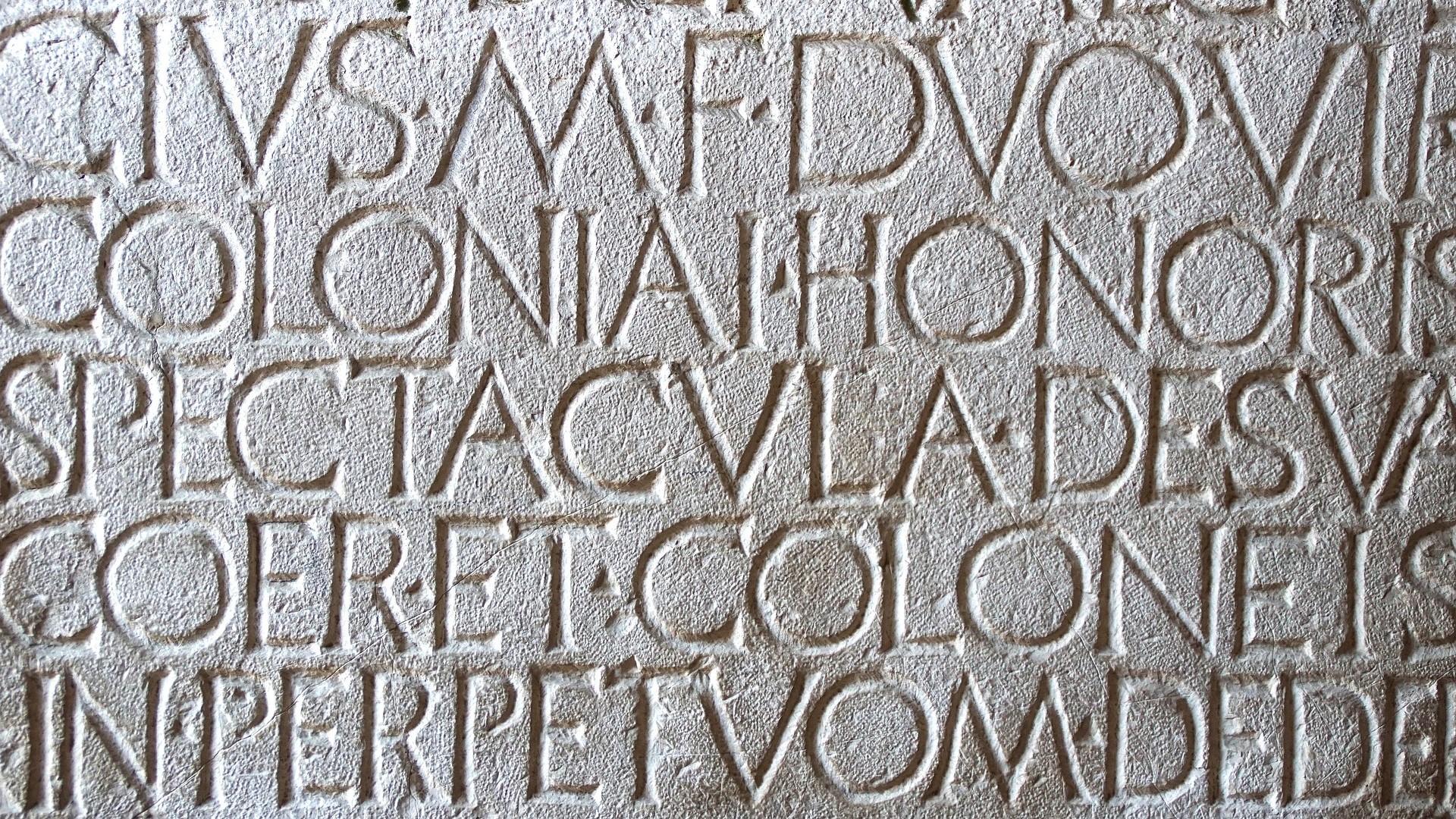
La domanda che spesso gli studenti di latino e greco pongono ai loro docenti – «Professore, dobbiamo tradurre letteralmente?» – può raccontarci molto di come gli studenti apprendano queste antiche lingue e di come si rapportino con esse. Un dibattito – quello su natura e tecnica della traduzione – dalle radici storiche profonde, con protagonisti come San Girolamo, che ha esplorato attentamente il tema dello “scontro” tra traduzione letterale e cosiddetta libera.
Traduzione libera o traduzione letterale?
Chi scrive è un docente che (in ambito liceale e universitario) aderisce, per l’insegnamento della lingua latina, a una famiglia di metodi di natura induttivo-contestuale ovvero “naturali” (comunemente noti con il poetico appellativo di “latino vivo”) e, anche in virtù di questo profilo glotto-didattico, quando gli studenti mi chiedono se io preferisca una traduzione letterale del testo latino proposto, rispondo che non esistono traduzioni letterali o libere, ma solo traduzioni corrette, ovvero traduzioni che comunichino adeguatamente il messaggio veicolato dalle parole dell’autore. Una buona traduzione non rende le parole, ma piuttosto traghetta nella lingua d’arrivo ciò che l’autore aveva intenzione di dire: ciò che chiamiamo il senso.
Traduzione e finalità didattiche
Una traduzione corretta, d’altro canto, è fondamentale per valutare con affidabilità le competenze linguistiche degli studenti, ma molti docenti continuano a richiedere traduzioni letterali: un’abitudine radicata in quella tradizione educativa che, a partire dal XVIII secolo, ha enfatizzato lo studio delle strutture grammaticali astratte con finalità generalmente formative, a danno della lettura e comprensione dei testi e trascurando così l’obiettivo principale dell’insegnamento delle lingue antiche.
Tutto questo entra, inoltre, in patente contraddizione con ciò che si legge nelle Indicazioni nazionali per l’insegnamento della lingua latina, ove si afferma che lo studente dovrebbe essere in grado di leggere, comprendere e tradurre testi, con un focus evidente sulla comprensione, piuttosto che sulla semplice memorizzazione e assimilazione di regole grammaticali. Tuttavia, nella pratica scolastica quotidiana, la traduzione dal latino viene utilizzata come mero strumento per verificare conoscenze il più delle volte strettamente grammaticali: la competenza di lettura è semplicemente scomparsa dai radar, mentre quella di comprensione del testo lascia ampiamente a desiderare, come qualsiasi docente di latino e greco potrà candidamente riconoscere sulla base della propria stessa esperienza professionale.
Il lato oscuro della traduzione letterale
Va poi rilevato, che indurre lo studente ad attenersi a una traduzione strettamente letterale significa di fatto incoraggiarlo a non fidarsi delle proprie competenze linguistiche, il cui sviluppo dovrebbe invece essere lo scopo primario dell’insegnamento linguistico, anche latino.
Inoltre, molti tra gli studenti, che optano per l’utilizzo della traduzione letterale, dichiarano di farlo solo per evitare il pericolo di compiere delle scelte difficili, o perché non riescono a comprendere il testo che leggono, con il logico risultato di traduzioni spesso goffe, talvolta scarsamente comprensibili e, oltretutto, poco o per nulla significative come feedback valutativo, poiché sono un tentativo di occultare precise lacune linguistiche. Gli studenti dovrebbero, al contrario, essere guidati dal docente nella comprensione di cosa sia effettivamente una traduzione, nonché incoraggiati a sviluppare ordinatamente le proprie competenze interpretative, piuttosto che limitarsi a versioni “meccaniche” che, nella mente dello studente medio, finiscono per essere l’unica legittimazione delle cosiddette traduzioni “libere”, le quali divengono quindi solo un’inutile perdita di tempo, oltre che uno scomodo e, di nuovo, inutile rischio.
La logica conclusione
La traduzione corretta deve veicolare il messaggio dell’autore, piuttosto che limitarsi a una corrispondenza letterale ad verbum; e le necessità di verifica grammaticale non possono snaturare la pratica traduttiva e didattica. Gli studenti, spesso per loro stessa ammissione, ripiegano paradossalmente sulla traduzione letterale perché non conoscono abbastanza bene il latino, sperando almeno di dimostrare delle conoscenze grammaticali, laddove non siano in grado di attestarne di linguistiche. Dal canto suo, la traduzione letterale, quand’anche formalmente corretta, non di rado non è in grado di riflettere le effettive competenze linguistiche dello studente e può così finire per mascherare importanti lacune didattiche. È quindi essenziale riconsiderare e ripensare profondamente le pratiche di insegnamento del latino, senza dubbio per allinearle meglio agli obiettivi di apprendimento, ma soprattutto per promuovere una comprensione reale e più profonda della lingua.
Proprio riflettere sulle esperienze degli studenti e sulle nostre pratiche di insegnamento può aiutarci a riconoscere le aree in cui sia necessario apportare delle modifiche. Infatti, solo affrontando con umiltà le nostre convinzioni educative potremo migliorare le pratiche didattiche di insegnamento del latino e rispondere adeguatamente alle esigenze dei tempi e dei nostri studenti, contribuendo così al loro sviluppo linguistico e umano.
N.B.: Il presente articolo riporta una sintesi dei contenuti presenti in un testo più approfondito che trovate allegato qui in basso. Nella versione integrale le tesi dell’autore sono estesamente e adeguatamente argomentate.










